La bellezza della serie Il Commissario Ricciardi che trasporta a fumetti i romanzi di Maurizio De Giovanni è tale che noi di Fumetti Avventura non potevamo fermarci ad una sola recensione e quindi in occasione dell’uscita della versione da edicola, eccoci a presentarvi la nostra seconda recensione (dopo quella scritta per l’edizione da libreria) scritta da Chiara Cvetaeva come al solito con passione e acutezza!
Il mare non bagna Napoli: così s’intitolava una splendida raccolta di racconti e reportage di Anna Maria Ortese. Parafrasandola, il mare no, ma la pioggia sì: così è, almeno, nell’ultimissimo atto di questa tetralogia “stagionale”. Siamo nell’ultimo scorcio di ottobre, a ridosso del giorno dei morti. È autunno inoltrato e di vignetta in vignetta sembra quasi di avvertirlo, lo scroscio della pioggia incessante. Si respira un’aria greve, pesante, viziata, che trova una resa perfetta nella tonalità bruna, quasi color seppia delle belle tavole di Siniscalchi. Il tratto scabro, a momenti nervoso, è quanto di più appropriato e opportuno si potesse chiedere per una storia così.

Il giorno dei morti – L’autunno del Commissario Ricciardi
In nessuna delle tre storie precedenti – che io ricordi – è accaduto di sorprendere sul volto di Ricciardi un sorriso che non fosse un accenno, un abbozzo, una smorfia dolente. Ne Il giorno dei morti, Ricciardi non solo non sorride, ma si mostra con una faccia patita e scavata. Perennemente fradicio di pioggia, si trascina per le strade di Napoli indagando su un caso che non è un caso: tutto, infatti, autorizzerebbe a ritenere che lo scugnizzo ritrovato morto a Capodimonte sia stato vittima di un accidente, di una pura fatalità. Spinto dalla morsa della fame, il piccolo Matteo (familiarmente detto Tettè) avrebbe ingerito del veleno per topi. Mancano del tutto segni di violenza che possano essere messi in relazione con il decesso. Un fatto da archiviare, quindi. E d’altra parte, nella città che il Regime ha bonificato da ogni crimine e restituito a una specchiata moralità non potrebbe essere altrimenti.
Ciononostante, però, Ricciardi si intestardisce, e per quanto scosso dai tremori della febbre, scava nei trascorsi del povero Tettè, e dovunque vada, lo accompagna una presenza discreta, quella del cagnolino che con Tettè aveva condiviso molti giorni sciagurati e poco pane: alla bestia, infatti, l’orfanello aveva destinato i pochi bocconi ch’era riuscito con fatica a procacciarsi.
Scava e riscava, il commissario porta allo scoperto un porcilaio, in cui il più pulito è zozzo da far schifo. Preti strozzini, dame di carità con l’anima più nera della pece, madri snaturate e ancora altri trovatelli che una vita di stenti e angherie ha incattivito prima del tempo. Escluso il cane, non ce n’è uno che ne esca bene.
La storia è di quelle che prendono allo stomaco. La nausea non è soltanto un’affezione fisica. La nausea è anche un sentimento, forse il più forte che la lettura di quest’albo mi abbia suscitato. La scelta di un registro realistico nella restituzione degli ambienti ne acutizza ancora di più gli effetti. Anche in
Deadwood Dick, altra felicissima trasposizione in vignette e balloons di un’opera romanzesca, si incappa spesso in immagini forti. In quel caso, tuttavia, c’è comunque un gusto per il grottesco che, permeando i disegni, stabilisce un diaframma e aiuta il lettore a mantenere le distanze. In questo caso no.
L’amore è il solo riscatto possibile. Parrà banale, ma è una verità, e una banalità può essere vera nella stessa misura in cui una verità può essere banale. L’amore che traspare da un gesto di compassione. O quello sublimato dal sacrificio di sé e della propria felicità. O ancora quello che balena negli occhi di un cane. Nella conclusione delle Stagioni di Ricciardi c’è tutto questo. E di sicuro non è poco.
I tempi sono ormai maturi per fare una valutazione “a consuntivo” di questa serie, che resta per me uno dei prodotti migliori, di più pregevole fattura che la fucina di via Buonarroti 38 abbia dato alle stampe quest’anno.
Non era facile ritagliare per un personaggio romanzesco tanto amato dal pubblico un abito di foggia fumettistica, che gli calzasse bene e fosse fatto su misura per lui. L’operazione però è riuscita: non solo si è schivato il rischio concreto di una trascrizione meccanica, fredda e senz’anima di una storia già bell’e data, ma se ne è mantenuto quanto più possibile lo spirito, pur ricavandone, a conti fatti, qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo. C’è un adagio latino che gli storici della lettura e i teorici della ricezione amano citare: pro captu lectoris habent sua fata libelli, e cioè “secondo le capacità del lettore i libri hanno il loro destino”. Tuttavia, in certi casi, sembra le storie abbiano una loro singolare autonomia: decidono il loro corso indipendentemente dagli autori che ci mettono o rimettono mano, dai lettori che le leggono ora in una veste, ora in un’altra. Ho l’impressione che questo accada soprattutto quando gli ingredienti di una storia siano tali da dar luogo a una speciale alchimia.
Mi scuso per il tono divagatorio, per la lungaggine, per tutte le altre eventuali manchevolezze che giustamente potranno essere imputate a questo pezzo. Ma non me la sentivo di scrivere una “recensione di servizio”. Ricciardi meritava qualcosa di più.





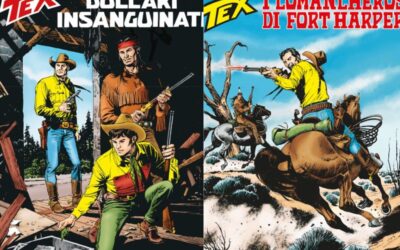



0 commenti