È uscito ormai da oltre un mese (e molti avranno già trovato in edicola il numero 9) l’ottavo numero della miniserie Cani sciolti, progetto molto innovativo per temi trattati all’interno della linea Audace. A Gianfranco Manfredi è stato proposto di rievocare in forma narrativa le vicende dell’Italia dal 1968 in poi attraverso gli occhi e la vita di sei ragazzi (principalmente) che si incontrano durante la contestazione universitaria a Milano nel 1968 e restano legati negli anni a venire. Dal punto di vista della scelta editoriale le storie sono raggruppate per due numeri alla volta, mentre dal punto di vista narrativo sono continui i passaggi tra piani temporali che hanno finora toccato un arco di tempo che va dagli anni della seconda guerra mondiale (o anche prima) fino a quasi i nostri giorni (proprio nel numero 8 La strage che qui recensiamo c’è una sezione ambientata ai primi anni 2000).
La strage – Cani sciolti n.8
Soggetto e sceneggiatura: Gianfranco Manfredi
Disegni: Roberto Rinaldi
La doppia storia Autunno caldo e La Strage ha come momento cruciale la strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969, simbolo di un periodo di violenza e alta tensione nonché di instabilità e incertezze sul futuro politico e istituzionale della nazione italiana. Manfredi descrive con schiettezza gli attimi dell’esplosione e aiutato dalle splendide matite di Rinaldi ci fa visualizzare gli impressionanti funerali in piazza Duomo. Il tema del chi è stato, del perché, dei depistaggi da spionaggio internazionale è toccato dallo scrittore ma come al solito più che la volontà di dire quale è stata la verità (e chi la sa del resto?), a Manfredi importa farci entrare nel sentimento delle persone che hanno vissuto quei momenti: i sei ragazzi ‘cani sciolti’, il padre poliziotto di Turi, il dott. Bignami, padre di Marghe, le ricche borghesi che frequentano i negozi chic di via della Spiga… e non solo, con una scelta che ho molto apprezzato e che mi ha avvicinato ancora di più al fumetto, Manfredi sceglie di raccontare di una ‘tradizione’, nel senso letterale del termine, ovvero di un passaggio di esperienze tra genitori e figli: Deb sposato e con due figli ormai grandi agli inizi degli anni 2000 racconta alla figlia quello che lui ha capito di quei convulsi anni. Questa eredità di giudizi è per me il vero cuore di volta di questa serie così particolare e ‘audace’.
E per il resto? Il racconto ovviamente si concentra sui nostri protagonisti e sullo sviluppo delle loro scelte di vita e di fatto quella che si sta sempre più definendo è quella di Milo che vuole intraprendere la carriera musicale (e vorrebbe con i suoi testi anche sostenere la libertà dei diritti degli omosessuali). Bello in questo senso il dialogo tra Milo e la madre che per ora si era mostrata apparentemente distaccata e sempre un po’ scettica verso il figlio: Milo di fronte alla strage di piazza Fontana si chiede che senso abbia continuare a cantare e la madre gli risponde: «È proprio quando il mondo va a rotoli che c’è più bisogno di canzoni! Non rinunciare mai a cantare, Milo! Se no, vuol dire che non ci sei portato!». Un’altra figura di genitore (come Deb con sua figlia a inizio 2000) che si mostra ‘vero educatore’ nel dare coraggio al figlio nell’affrontare la realtà.
Due parole anche sul lavoro di Roberto Rinaldi che ci regala ancora una Milano viva e drammatica, vera e non edulcorata. Un grande artista che sa offrire la sua arte alla narrazione grazie anche ai silenzi e ai volti dei personaggi.
A tra pochi giorni per la presentazione del numero 9: Cartoline dalle vacanze.





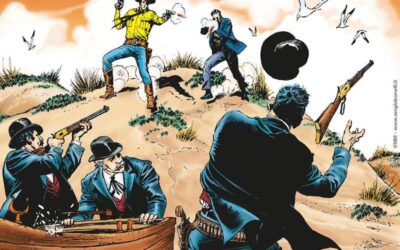
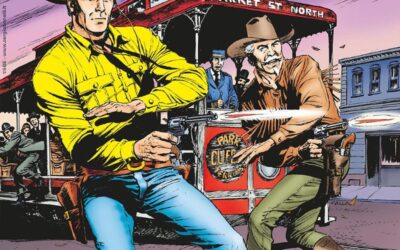


0 commenti