Come promesso, dopo la recensione di Chiara Cvetaeva, eccovi il controcanto di Giacomo Mrakic su La Dottrina, opera giovanile di Alessandro Bilotta e Carmine Di Giandomenico ora ripubblicata e rieditata per i tipi di Feltrinelli Comics.
Quando ci si approccia alle opere di Bilotta bisogna avere mente sgombra e solida capacità di cogliere i numerosi riferimenti che l’autore dissemina nel fumetto. Meglio ancora probabilmente sarebbe avere una conoscenza a 360 gradi, vista la sua capacità di riallacciare al termine della storia persino il più insignificante particolare.
Come già era stato rilevato da me e dalla mia sodale Chiara nelle Antilogie, il pensiero e lo stile di Bilotta mantengono intatto e fresco un chiaro marchio di fabbrica, che non si smentisce nemmeno ne “la Dottrina”. Il concetto di circolarità, ripetizione, pianificazione si mantengono inalterati, dando comunque una sensazione di rinnovamento, nell’attesa di un climax quanto più inaspettato. Non manca inoltre il chiaro riferimento al pensiero gnostico, tanto caro all’autore, ma questo è un concetto che mi riservo di analizzare più avanti. La Dottrina ci trasporta in un mondo distopico che richiama, fin dagli inizi, gli universi trasposti in letteratura da Philip K. Dick, Turtledove e Orwell.
Un mondo imperfetto nella sua perfezione, il migliore degli incubi possibili, dove un regime dittatoriale e onniveggente controlla ogni aspetto della vita sociale, compresa la capacità di provare sentimenti. L’universo dove si svolge La Dottrina è l’incarnazione più bieca e forse più assurda degli eccessi dei regimi totalitari: la vita non è un bene a disposizione, ma tutto è volto al raggiungimento di un fine predeterminato di cui solo le menti più illuminate sono a conoscenza. Tutto pare portarci alla mente una severa critica alle realtà dei regimi totalitari, sia di stampo politico che teocratico. È molto interessante il richiamo ad un nemico esterno, che non viene mai nominato né descritto, ma che viene percepito solo come una minaccia e che fa si che la popolazione viva in un terrore costante, diffidando anche del proprio vicino. La delazione è abituale e i pochi privilegiati vivono parassitando gli altri, in un crescendo di dipendenze da droghe o altri palliativi per esulare dall’orrore del quotidiano. La cultura è bandita, la letteratura ovviamente è svanita, addirittura sono scomparsi i sogni, e proprio dal sogno del cittadino Zeccaria prende avvio la narrazione.
Il sogno diventa un veicolo per evadere, un modo per aprire altri universi, altre realtà. L’autore, non nuovo alla conoscenza della filosofia gnostica, ci lancia vari rimandi nell’arco della narrazione, facendoci comprendere come sia necessario per l’uomo elevarsi e non accettare incondizionatamente ciò che ci viene trasmesso. Il cammino di Zeccaria nel recarsi a lavoro, anziché prendere il torpedone diventa pertanto una metafora della ricerca interiore della verità. Il cammino come fonte di riflessione, come modo di riappropriarsi di sé.Nonostante tutti questi riferimenti però, l’impressione che traspare, ad un profano che si appresti a leggere “la dottrina” è un senso di vertigine di disordine. Rimane un senso di incompiuto dal quale difficilmente si riesce ad uscire con delle certezze.
La sensazione che mi ha lasciato, almeno personalmente, è quella di un’opera alta, per lettori di livello, capaci di comprendere i numerosi riferimenti non solo ad altre opere, ma anche e soprattutto al pensiero filosofico. Come non vedere in Taddeo e nell’importanza del racconto orale come forma di trasmissione della conoscenza e come modo per non addormentare la fantasia un rimando al mito della caverna di Platone? Come non vedere un richiamo a Brasil, Blade Runner o a Minority Report nell’associazione tra numeri e parole? La matematica è logica e la logica muove il mondo, ma chi non ha i mezzi per comprendere entrambe diventa parte della classe sociale inferiore e come tale diventa un pesce in un mare di squali. Molto interessante il rapporto che intercorre tra la Smorfia e il Nocchiere; un rapporto antitetico che pure sfocia in una passione, in un amore impossibile che forse non è mai stato, narrato tra un amplesso e una poesia, dove amore e morte si fondono insieme per un fine più grande.
Tutto nel mondo della Dottrina è ragione, tutto è organizzato e predeterminato, e niente è lasciato al caso, nemmeno la rivoluzione o l’intervento della Smorfia. Ma proprio in questa realtà magistralmente gestita da Bilotta l’unica falla diventa appunto lo sviluppo della trama. Come già detto, niente è lasciato al caso, ma la necessità di richiamare, di inserire aspetti essenziali e importanti per la chiusura della storia, la maniacalità dell’autore, di non lasciare niente al caso, finisce per appesantire la storia, facendo perdere di vista a noi poveri neofiti, il bandolo della matassa.
Che dire pertanto de La Dottrina? Indubbiamente è l’ennesimo capolavoro di Bilotta, che in parte conferma quanto già visto con Mercurio Loi, toccando alcuni aspetti cardine che si confermano marchi di fabbrica dell’autore: la circolarità, l’innocenza del bambino come chiave di comprensione della realtà, l’importanza del libero arbitrio e la presa di coscienza; dall’altro però, in un turbinio citazionistico di alto livello, dove filosofia e gnosticismo la fanno da padrone, si ha la sensazione di un’opera iniziatica, che, come il Flauto Magico di Mozart, può essere letta su un doppio piano di comprensione, con il rischio di trasformarla in un fumetto di nicchia, ristretto a pochi prescelti.





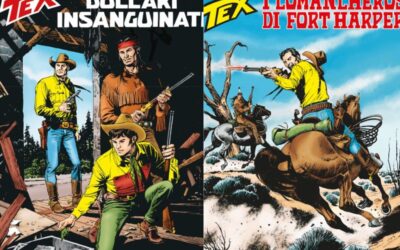



0 commenti